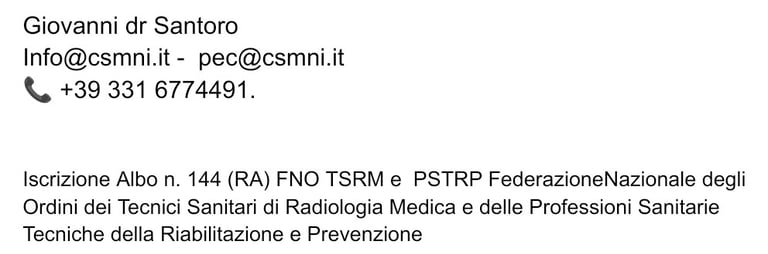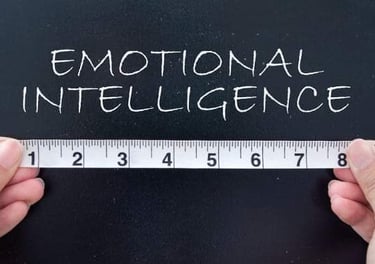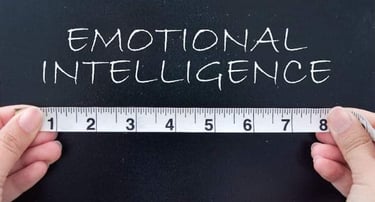La violenza trascina il Sindaco di Cervia
una pausa caffè amara
12/22/20253 min read


Queste righe non sono un commento sui fatti — che spetta alla magistratura accertare — né una difesa di parte. Sono una riflessione, forse scomoda, sul metodo con cui trasformiamo la complessità dei conflitti umani in sentenze mediatiche istantanee. Mi chiedo che modello educativo stiamo offrendo a una città quando la tutela della privacy e il percorso della giustizia cedono il passo alla velocità dello scoop.
Ore 17.00. Pausa caffè. Riapro un articolo iniziato stamattina e sento quello sconcerto silenzioso che non è rabbia, ma fatica a capire dove stiamo andando. Titoli forti, ricostruzioni nette, giudizi già confezionati. Il processo arriverà tra mesi. Ma intanto qualcuno ha già pagato tutto, pubblicamente. Non sto difendendo nessuno.
La violenza e il femminicidio restano inermi e indifendibili. Su questo non c’è discussione. Ma c’è una domanda che continua a tornarmi in testa, ed è scomoda per tutti: se l’atto finale è il punto di non ritorno, giustamente punito, chi guarda il percorso che porta fin lì? Anni di conflitti, pressioni quotidiane, denunce, controdenunce, relazioni che diventano trincee.
E allora la frase provocatoria, quella che nessuno ama leggere: uomini, donne, denunciate prima. Prima che tutto diventi irrecuperabile. Prima che resti solo un titolo. Prima che la complessità venga cancellata. Perché le denunce per pressione psicologica, mobbing relazionale, alienazione, esistono da entrambe le parti. Solo che alcune fanno notizia, altre no. Non per fare paragoni tra vittime, non per giustificare nulla, ma perché semplificare non educa.
Educare significherebbe dire che la violenza non nasce all’improvviso, il silenzio non è sempre innocente, il “prima” conta quanto il “dopo”. Sparare sentenze mediatiche subito rassicura. Pensare, invece, disturba. E forse è proprio questo che manca: la voglia di disturbarsi un po’, anche davanti a un caffè.
Se fosse stata davvero un’analisi fredda, tecnica, forse l’intelligenza artificiale avrebbe scritto solo un trafiletto. Avrebbe limitato il discorso a dire che la notizia esiste per il ruolo pubblico del sindaco e che questioni legate alla violenza attraversano la sua casa. Punto. Senza sociologia improvvisata, senza politica emotiva, senza sentenze morali anticipate.
Torno al lavoro con un mezzo sorriso e penso: da qui voglio guardare le cose. Questa è la mia vera libertà raggiunta.
Per cui, sindaco, non sei sicuramente di un partito che stimo particolarmente, ma sei stato votato. E per questo continui a fare il tuo lavoro fino a quando la giustizia farà il suo decorso. Solo alla fine si potrà dire se hai fatto bene a continuare oppure se sei stato uno che doveva fermarsi prima.
Educare alla non violenza, alla gentilezza e alla coscienza significa educare l’intera estensione viva di una città. Non hanno certo bisogno di capirlo quelle duecentocinquanta teste dai capelli bianchi che governano: il tema lo conoscono fin troppo bene. Loro, semmai, sono obbligate a rispondere a un sistema, alle sue regole, ai suoi tempi. Ma una città non è lì dentro. L’estensione reale supera le centocinquantamila persone ed è lì che si gioca tutto.
Questo non so nemmeno se si possa chiamare governare; forse è semplicemente educare in modo diverso. Non sono rattristato per quella piccola parte, sono amareggiato per il modello che diamo. Perché la domanda vera è un’altra: cosa penserà la media della popolazione territoriale davanti a tutto questo?
Anche a me, a dirla tutta, la verità nel lungo termine non ha mai davvero ripagato. Un tempo i giornali e i giornalisti correvano, scavavano, si nascondevano per arrivare alla verità, non allo scoop. Oggi spesso sembra il contrario. Ed è allora che mi chiedo se questa sia davvero l’educazione mediatica che vogliamo dare.
Mi guardo indietro e ripenso a un amore della mia giovinezza. Otto, nove anni di una passione che era un incendio: ci siamo amati, ci siamo spinti, ci siamo provocati, siamo caduti e ci siamo rialzati, dandoci quegli “spintoni” che solo chi vive una relazione viscerale conosce. Oggi, dopo trent’anni, ci sentiamo ancora ogni settimana. Se qualcuno avesse scattato una foto in uno dei nostri momenti di crisi, oggi saremmo in un fascicolo o in un titolo di giornale. Eppure, in quel conflitto c’era vita, non sottomissione.
E allora la domanda si fa ancora più sottile e disturbante: che cos’è, davvero, la violenza?
È violenza l’urto di due anime che non sanno come incastrarsi ma continuano a cercarsi per tredici anni, passando attraverso figli, carriere e campagne elettorali? O è violenza quella di chi, oggi, prende un frammento di vita, lo strappa al segreto e lo sbatte su un giornale come sentenza, ignorando tutto il “bene” e la complessità che ci sono stati nel mezzo?
Forse la violenza più subdola non è solo quella che accade tra le mura di casa, ma quella di una società che non accetta più le zone d’ombra.
Se cancelliamo questa sfumatura, se trasformiamo ogni caduta in un atto d’accusa eterno, non stiamo educando nessuno: stiamo solo distruggendo il diritto di essere complessi.
E qui la risata si fa inevitabile. Perché in un posto come Cervia, dove le pietre si conoscono meglio degli umani e dove si è appena passata una campagna elettorale di quelle in cui per un voto ci si fa le scarpe a vicenda, quel dato di tredici anni fa era rimasto lì, in silenzio sotto i portici.
In questo caso, la colpa educativa è di chi ha proposto quel nome come candidato.